Ciò che tarda avverrà
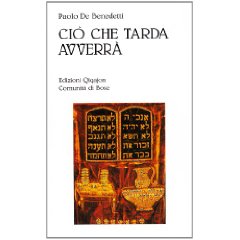 L’uomo biblico, e l’ebreo sempre, crede – non spera – che ciò che tarda avverrà. Di questa fede, il giubileo è un segno, anzi una parabola. La prima volta che questo libro mi è capitato tra le mani sono stata attratta da queste parole, che la casa editrice aveva stampato sulla fascetta che sigillava la copia del volume e non ho potuto fare a meno di prenderlo e iniziarne la lettura, cercandole, per scoprire che così si conclude questo denso libro, formato da ventidue brevi riflessioni una per ogni lettera dell’alfabeto ebraico. Partendo dalla Bibbia, De Benedetti si rifà agli insegnamenti degli antichi rabbini e in particolare al Midrash, spiegando che pur dovendo fare i conti, come tutti coloro che leggono la Scrittura, con il metodo storico-critico, ha “anche ‘creduto’ alla verità dei personaggi e degli eventi biblici, ‘come se’ fossero letteralmente reali”.
L’uomo biblico, e l’ebreo sempre, crede – non spera – che ciò che tarda avverrà. Di questa fede, il giubileo è un segno, anzi una parabola. La prima volta che questo libro mi è capitato tra le mani sono stata attratta da queste parole, che la casa editrice aveva stampato sulla fascetta che sigillava la copia del volume e non ho potuto fare a meno di prenderlo e iniziarne la lettura, cercandole, per scoprire che così si conclude questo denso libro, formato da ventidue brevi riflessioni una per ogni lettera dell’alfabeto ebraico. Partendo dalla Bibbia, De Benedetti si rifà agli insegnamenti degli antichi rabbini e in particolare al Midrash, spiegando che pur dovendo fare i conti, come tutti coloro che leggono la Scrittura, con il metodo storico-critico, ha “anche ‘creduto’ alla verità dei personaggi e degli eventi biblici, ‘come se’ fossero letteralmente reali”.
La prima riflessione, contrassegnata dalla lettera alef, offre una sorta di introduzione a tutto il lavoro svolto dall’autore, e fa riferimento alla molteplicità di offerta di senso della Scrittura, parlando anzi di un settantunesimo senso, inteso come pluralità infinita di sensi che possono esservi trovati. Il numero settanta è, nella concezione ebraica, abbinato alla totalità (il mondo era costituito da settanta popoli e a tutti era stata offerta la Torah), settantuno è la totalità più qualcosa. “Il settantunesimo senso è una parte rispetto al tutto, al tutto dei sensi, ma deve esserne consapevole, avere la consapevolezza di essere solo parte. E solo parte vuol dire: consapevolezza che c’è il tutto”. Noi siamo l’ultima fonte di senso della Scrittura, osserva De Benedetti.
Nei commenti ebraici si può trovare: “Questo versetto biblico dice: Spiegami!”. È un’osservazione interessante: la Scrittura non è un vademecum di formule o di ricette già fatte e pronte per l’uso, è un tesoro di sensi, una miniera di significati, che si offre alle nostre capacità di comprensione e ci invita alla ricerca. Le vie che a tali significati conducono sono tre: il canone, l’insieme stesso dei libri biblici e la comunità dei credenti in ascolto. Il canone, quella realtà che definisce quali testi sono Parola di Dio, non è tuttavia oggettivamente individuabile, è molteplice: canone ebraico, canone cattolico, canone protestante. Allo stesso tempo, non è un monolite l’insieme delle Scritture, in essa troviamo una grande quantità di scritti: poetici, storici, legislativi, favolistici, sapienziali, profetici, un composto di rimandi e di richiami, di riprese e di innovazioni, spesso di contrasti. Infine, non è unica la comunità. Sono molte le comunità, talora non in comunione tra loro. Non solo. Ogni comunità è articolata nello spazio e nel tempo, trova la sua voce concreta nei singoli credenti. Ecco perché è possibile parlare di settanta significati per ogni versetto biblico, anzi di un settantunesimo non ancora scoperto, che attende il suo interprete, ma che non è il significato chiave. È uno dei tanti sensi che arricchiscono il diadema delle molteplici interpretazioni che sorreggono e portano la Parola attraverso la storia e che solo “la comunità delle comunità, nel giorno ultimo, insieme con Dio, potrà vedere compiuta”.
Nel Midrash Rabbà all’Esodo c’è un testo, da cui si può partire per chiarire come fa l’autore il concetto: “Rabbi Tanchumà disse: ‘La voce di Dio sul Sinai fu intesa da ciascuno secondo la sua capacità di intendere. Gli anziani la intesero secondo la loro capacità, i giovani secondo la loro capacità, e così anche i bambini, i lattanti e le donne. Perfino Mosè la intese secondo la sua capacità. Perciò sta scritto (Es 19,19): Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce [in questo versetto si potrebbe anche tradurre: con un tuono]. Ciò significa: con una voce a cui Mosè potesse reggere’” (5,9). Un passo avanti è compiuto con la citazione del salmo 62, 12, fatta da Abbajè: “Una cosa ha detto Dio, due ne ho udite”. Due ne ho udite, io: perché l’offerta della parola è per molti, ma è pure molta. E tuttavia rabbi, Jishma’el dice ancora una cosa che non si deve dimenticare: “La Torà parla secondo la lingua degli uomini” (Sifrè Nm 15,31). Il cerchio si chiude: le lingue degli uomini sono molte, e le lingue degli uomini possono dire solo certe cose e non possono dire tutto. “Le parole, della Torà crescono e si moltiplicano (Chaghigà‘3ab)”. Dunque, non ci si può avvicinare ai testi sacri, pensando di trovarvi una risposta preconfezionata, adatta per tutti e valida per ciascuno, in realtà, sostiene De Benedetti, l’atteggiamento del lettore deve essere quello di chi si interroga e interroga la Scrittura, partire dalla domanda , una domanda incessante.
“Occorre piuttosto porsi dietro alla parola di Dio, come i magi dietro alla stella, e seguirla là dove, uscendo dal tempio rovinante della cristianità, andrà a posarsi. Non è, oggi, una stella così lucente da offuscare tutte le altre stelle anzi si lascia confondere abbastanza con alcune di esse; questo è nel disegno divino, che volle salvare Israele mediante un uomo nascosto in una bara, e non pensa la salvezza del cristianesimo come una solenne processione da uno a un altro tempio, i re in testa alla processione, il popolo in coda. Ma c’è una differenza, tra l’andar dietro a questa stella e la provvidenziale fuga a Javne di rabbi Jochanan: che allora bastò la fuga di un uomo a salvare l’ebraismo, oggi ogni cristiano è personalmente impegnato a uscire dal vecchio tempio e seguire la stella destinata a condurre proprio lui. Solo così, alla fine, tutta la chiesa di Dio si troverà in salvo, in questo mondo profano ma così caro a Dio”.
L’autore si addentra in riflessioni molto avvincenti su fatti e personaggi (Abramo, Mosé, Aronne), utilizzando i commenti e i racconti dei vari rabbi della tradizione, che ci permettono di penetrare nella cultura ebraica, sulla quale s’innesta il cristianesimo, e di cogliere alcuni aspetti della mentalità dell’uomo biblico e del suo concetto di Dio, estremamente diverso dal Dio dei filosofi.
Quando il Signore si rivolge a Mosé nel roveto ardente dice ‘io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il dio di Giacobbe’. “Ma chi è Dio, di chi Dio è Dio? Interessante la correlazione che Paolo de Benedetti fa tra questa affermazione e le nostre domande su Dio. la risposta non può che essere una, anche se noi spesso non ne realizziamo la profonda innovazione, rispetto alle religioni non bibliche e alle speculazioni filosofiche: “Dio si manifesta esclusivamente come Dio di qualcuno. Non è Dio del cielo, non è Dio del paese, non è Dio dell’istituzione regale, bensì Dio di un arameo errante: cioè di un uomo che non ha patria e ovunque è straniero. Quest’uomo è così caro a Dio che Dio in un certo senso prende il suo nome; infatti che cosa significa Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe (gli aramei erranti) se non che Dio ha un nome soltanto in riferimento a coloro che egli ama? L’elezione e l’alleanza sono già contenute nel nome con cui Dio, nel roveto ardente si manifesta a Mosè”.
Errante, come gli Aramei, d’altro canto, sarà l’arca che contiene il Santo, che manterrà sempre, anche quando verrà posta all’interno del Tempio, delle stanghe che devono essere infilate negli appositi anelli per poterla portare con gli uomini: Dio cammina con loro, l’arca è portata da uomini, i leviti, quindi l’Onnipotente tiene il passo degli uomini, se così si può dire, afferma De Benedetti. Ciò che compete all’uomo è cercare, scavare trai sensi della Scrittura e nei mutamenti del tempo in cui vive “i segni di quel movimento che fu impresso nella creazione, e del quale egli deve sentirsi responsabile, non spettatore o vittima”. In questa ricerca, che è insieme annuncio della Buona Novella e testimonianza, ministri e fedeli camminano insieme, e i buoni ministri sono quelli che aiutano a farla comprendere: aiutano grazie alla spiegazione e al commento a “riconoscerne la provocazione permanente”. La parola trova sempre modo per rivelare se stessa, una volta, a chi sta in ascolto, in questo possiamo iniziare ponendoci come discepoli di chi è sapiente, ma attraverso lo studio progrediremo verso una sempre maggiore penetrazione della Parola e possibilità di metterla in pratica.
Un detto rabbinico dice “fatti un maestro e acquistati un compagno”, la comprensione del messaggio della rivelazione non è oggetto di una conoscenza intellettiva personale da opporre agli altri, nell’ebraismo la Torah è costantemente “masticata”, discussa, dibattuta nelle scuole rabbiniche e nelle sinagoghe, affinché da queste costanti dispute emerga un settantunesimo senso, tanto che si dice “ciò che un discepolo provato insegnerà davanti al suo maestro, anche questo è Tora di Mosè sul Sinài” (jpe’à 2,4). Con un’espressione molto bella Paolo de Benedetti dice: “il Maestro è quindi, e deve essere, come ‘l’unguento sparso’ (Ct 1,3), come un vaso di profumo aperto, secondo il paragone talmudico (‘Avodà Zarà 35b) deve diffondere profumo di torà e di azioni, deve essere un esempio e un testimone”.
Maestro e discepolo camminano, insieme a Dio, alla scoperta del Suo progetto non ancora svelato: “ecco paradossalmente, Dio ha dato all’uomo il compito, se così si può dire, di superarlo. Tutto questo si trova in maniera germinale già nel racconto della creazione. Dio crea le cose senza dar loro un nome, ma in Genesi 2,19-20 vuole che Adamo Dia un nome alle creature. Che vuol dire dare un nome alle creature? Vuol dire trasporre il creato di Dio in un creato di segni, di segni da vedere, da sentire, da dire. Questa è la creazione dell’uomo, questa è anche la cultura”. Questo è quello che maestri e discepoli studiando la Parola e scavando nella ricerca comune del settantunesimo senso possono fare.
E per iniziare, propongo una piccola provocazione: il titolo del libro fa riferimento ad un versetto della Scrittura, non riportato nel testo, ricercarlo e disputarne il senso, con un maestro e con un compagno, sarà il primo passo verso la sua realizzazione, che si verificherà allorché, finalmente, si potrà proclamare l’anno giubilare, quello della liberazione dagli idoli, re, signori: ciò che tarda avverrà!






